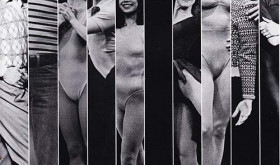Teatro Stabile Torino presenta:
Antonio e Cleopatra (1982)
Di William Shakespeare
- Interpreti: Adolfo Celi, Anna Maria Guarnieri, Sebastiano Lo Monaco, Alfredo Pea, Glauco Onorato, Elia Schilton, Claudio Ferrara, Alessandro Esposito, Gabriele Martini, Alberto Sorrentino, Beppe di Mauro, Roberto Pescara, Massimo Loreto, Emanuele Cannarsa, Anna Zapparoli, Pino Patti, Dorotea Ausenda, Enrichetta Bortolami
- Traduzione: Masolino D'Amico
- Musiche: Benedetto Ghiglia
- Scene: Mario Missiroli, Carlo Giuliano
- Costumi: Elena Mannini
- Adattamento e Regia: Mario Missiroli
Link Wikipedia
Adolfo Celi - Annamaria Guarnieri - Foto di scena
Programma di sala (pagine 24)
- La pace del "Padrone" (Lella Cracco Ruggini)
- Tradurre Shakespeare (Masolino D'Amico)
- Ridurre Shakespere (Pietro Ferrero)
- Il cast
- Foto di scena
Tradurre Shakespeare
Nelle sue conferenze Sul tradurre Omero poi riunite in volume, pietra miliare delle moderne teorie della traduzione, Matthew Arnold definì la traduzione ideale quella che riesce a ricreare nel suo pubblico sensazioni analoghe a quelle prodotte, nel suo pubblico e ai suoi tempi, dal testo originale. Si tratta evidentemente di una utopia: neanche i maggiori eruditi in circolazione possono conoscere, ovviamente, il tipo di effetto che Omero, o, per venire a noi, che Shakespeare suscitava nel contesto di una società remota. Ma proprio proponendosi come ideali irraggiungibili, le utopie aiutano a far funzionare meglio i compromessi su cui ogni esistenza necessariamente si fonda. E a temperare quella di Matthew Arnold c'è subito una riflessione limitatrice. "Sensazioni analoghe a quelle prodotte allora" significa infatti, inevitabilmente, "analoghe a quelle che oggi pensiamo che fossero prodotte allora". In altre parole, mentre il classico parla a tutti i tempi, il traduttore è al servizio esclusivo del suo: anche il grande traduttore. L'Omero settecentesco, in distici, di Alexander Pope parve imbevuto di spirito greco ai suoi primi lettori, oggi lo ammiriamo come capolavoro della letteratura inglese detta per il suo nitore "augustea"; ed è inutile dire che a noi gli stessi campioni di versioni da Omero in esametri tentate da Arnold per illustrare le sue affermazioni paiono eleganti brani lirici ottocenteschi, in stile romantico-crepuscolare. Dunque le traduzioni, anche le migliori, invecchiano in fretta, e bisogna rinnovarle continuamente. Gli originali, quando sono dotati di statura eccezionale, non invecchiano; ma non rimangono immutati neanche loro. Panta rei. Gli inglesi che ascoltano Shakespeare in inglese oggi non sono certo elisabettiani. Non soltanto non possono decifrare una quantità di riferimenti e di allusioni a circostanze di quell'epoca: ma addirittura un grande numero di parole adoperate da Shakespeare sono diventate incomprensibili, o hanno notevolmente modificato il loro significato. Così in tutti i tempi, a partire dalla Restaurazione (1660), già meno di un secolo dopo la sua morte, Shakespeare veniva messo in scena con aggiornamenti, tagli, aggiunte, e insomma con ogni sorta di concessioni al gusto dell'epoca nuova: e gli adattamenti andavano dai ritocchi alla lingua, all'intervento nelle trame. Notoria per esempio la sostituzione di un lieto fine a quello tragico di Re Lear, operata verso la fine del 600 e rimasta in auge per un secolo e mezzo. Il mito del rispetto del testo "originale" è nato nella nostra epoca, e ha dato origine a tutto un altro sistema di "aggiornamenti", nel quale ci riconosciamo: ossia a uno stile di regia il cui iniziatore fu, intorno agli inizi del secolo, Harley Granville-Barker, dove partendo dalla scommessa di non cambiare nemmeno una virgola del lavoro così come è stato tramandato, si affida il compito di porgerlo all'autorevolezza e alla convinzione degli attori, al ritmo, a soluzioni di scenografia suggestive di un palcoscenico diverso da quello invalso dopo l'età elisabettiana, ecc. Di tale stile è oggi maestra a tutto il mondo la Royal Shakespeare Company, con i suoi registi Trevor Nunn, John Barton, Terry Hands, e via dicendo. Il mito del rispetto del testo riguarda beninteso i paesi dove per ragioni di lingua il dettato shakespeariano è immodificabile. Là dove Shakespeare deve essere tradotto, molto, se non proprio tutto, è lecito: soprattutto là dove, come in Italia, non esiste nemmeno una traduzione consolidata dall'uso e divenuta quasi essa stessa un classico da resuscitare o contro cui misurarsi (è il caso della Germania, della Polonia). Condizione per certi aspetti addirittura invidiata dagli stessi anglosassoni, i quali talvolta sospirano al pensiero della disinvoltura con cui noi traduttori e registi possiamo chiarire un passo oscuro, rinfrescare un lazzo stantìo, modernizzare un'espressione, restituendole (o così ci illudiamo) tutto il mordente del caso. Non ci invidia invece, chi ama Shakespeare, la condanna a fare a meno del verso; la rinuncia programmatica al ritmo indescrivibilmente duttile della pentapodia giambica shakespeariana, non meno ampia, nella sua ricchezza espressiva, dalla terzina dantesca, unico esempio ad essa avvicinabile, forse, di medium egualmente convincente nel sublime e nello scurrile, nella passione e nel ragionamento, nel dimesso e nel sonoro. Collocandosi in un momento centrale dell'evoluzione del teatro poetico inglese, il blank verse di Shakespeare risulta equi distante dal metro melodioso ed eloquente di Marlowe, suo immediato predecessore, e da quelli dei successori, come Fletcher, nelle cui mani venne sempre più avvicinandosi alle cadenze della prosa e del parlato quotidiano: e per questo motivo è recitabile ed è stato recitato, in tutti i modi concepibili, al solito seguendo i gusti dei vari momenti storici. Le stesse parti sono state ascoltate in tutti i registri di una gamma che presenta a un estremo Betterton e gli altri esponenti tardosecenteschi e primosettecenteschi della cosiddetta "teapot school" o "scuola della teiera" (l'attore atteggiato per l'appunto a teiera, con una mano sul fianco e l'altra tesa, le gambe divaricate), immobile e declamatoria; e all'altro, i moderni esponenti del realismo, magari in abiti nostri contemporanei e con accento ineducato, da uomo qualunque. Ma per concludere. Perché ho parlato di nostra condanna a fare a meno del verso? Per due motivi, il più ovvio essendo l'assenza, in Italia, di un artigiano del verso all'altezza del compito. Il secondo motivo si riallaccia a quanto teorizzato da Matthew Arnold. Se il nostro scopo è tentare di riprodurre, traducendo Shakespeare, un effetto analogo a quello che presumibilmente Shakespeare produceva sul suo pubblico, ecco che, paradossalmente, non potremo tradurre Shakespeare in versi; o perlomeno, in versi-versi, in endecasillabi alla Vincenzo Monti, per intenderei. Questo produrrebbe infatti sul nostro pubblico un effetto di archeologico, di antiquato, che certo l'originale non produceva, in un'epoca in cui i versi erano la regola e non l'eccezione, in tutto il teatro non dichiaratamente comico. D'altra parte, sempre in base all'obiettivo indicato da Arnold, anche tradurre Shakespeare in lingua corrente e in prosa, come pure talvolta si fa, è frutto di un equivoco dalle conseguenze non meno gravi. I personaggi di Shakespeare non si esprimono in modo "normale". Pur figli di un'epoca che sognava l'eloquenza e che se ne inebriava, ben pochi fra gli spettatori di Antonio e Cleopatra sarebbero stati in grado di rivaleggiare con l'agilità la fantasia e la facondia di cui gli attori erano portavoce, in questo proponendosi loro come modelli da ammirare. Ecco dunque che il traduttore di Shakespeare deve porsi come primo scopo quello di mettere insieme una lingua che pur essendo comprensibile (per ovvi motivi) e scorrevole (altrimenti non si darebbe teatro), susciti almeno la sensazione, il ricordo, di uno stile elevato; crei l'impressione di un mondo in cui l'esprimersi sia connaturatamente alla portata di tutti; e contenga, magari senza esibirli, sotterraneamente, qua e là, i ritmi di un parlato ricreato da un mediatore fra la Vita e la sua rappresentazione. È difficilissimo.
MASOLINO D'AMICO